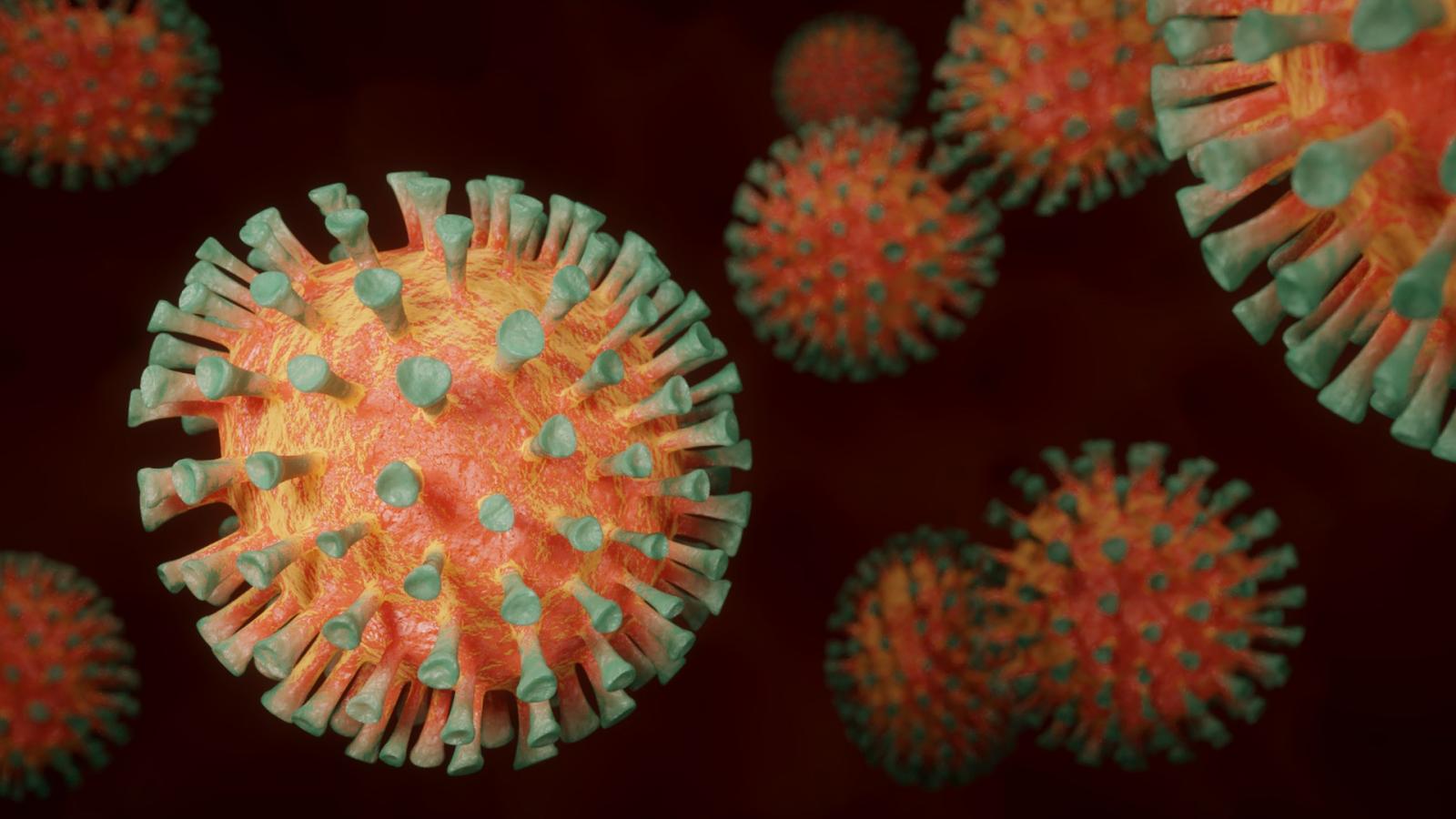Processo Alba Pontina: a parlare nell’Aula della Corte d’Assise del Tribunale di Latina il boss dei Di Silvio di Campo Boario, Armando detto “Lallà”
A sentirlo sembra quasi credibile tanta è la pervicacia con cui cerca di dissimulare la sua caratura criminale. È Lallà, il capo della famiglia Di Silvio di stanza tra Campo Boario e il Nicolosi che, dopo gli arresti della banda di Don’t Touch (Cha Cha e i fratelli Travali), aveva preso tra il 2016 e il 2018 il monopolio di una buona fetta dello spaccio a Latina (solo il quartiere Nicolosi è una miniera d’oro per lo smercio di droga), delle estorsioni e delle campagne elettorali tra Latina e Terracina.
Leggi anche:
BASTARDA PONTINA (Parte I)
Nega tutto, Lallà, e non poteva essere altrimenti. “Non sono un siciliano, non vengo da Corleone, sto qui in Sardegna a farmi il carcere in mezzo a persone che di reati ne hanno commessi veramente“.
“Io sono uno zingaro sfortunato, siamo una famiglia di straccioni, di morti di fame“. Questo è stato il tenore dell’interrogatorio di Armando “Lallà” Di Silvio incalzato dalle domande del sostituto procuratore della Repubblica di Latina Claudio De Lazzaro. Un piccolo zingarello di provincia, non di certo l’uomo senza il quale un’estorsione non veniva portata a compimento, un carico di droga non veniva prelevato dai maggiori broker della provincia (e oltre, non a caso è stato ricordato, ma da lui ovviamente negato, il carico rubato ai Moccia di Tor Bella Monaca), un conto non veniva regolato.
In sostanza, il boss di una delle famiglie Di Silvio di Latina ha sostenuto di essere un poveraccio che spacciava piccole quantità di droga, acquistate da Peppe il marocchino (di nazionalità) alle Autolinee. Una strana e involontariamente ironica assonanza con quell’altro marocchino, al secolo Giuseppe D’Alterio di Fondi, detto Peppe ‘O Marocchino, da sempre nel ramo nel narcotraffico pontino (oltre che al controllo del settore ortofrutticolo), con cui, secondo il collaboratore di giustizia Renato Pugliese, erano sì in affari i Di Silvio: prima Cha Cha, padre di Pugliese (basti vedere l’inchiesta LazialFresco dove furono indagati/processati sia Costantino Di Silvio detto Cha Cha che D’Alterio), poi i Di Silvio di Campo Boario, proprio tramite il predetto Pugliese che, in realtà, la droga la rubava al Marocchino fondano.
Leggi anche:
IL FLASHBACK CRIMINALE DI RENATO PUGLIESE – I CLAN, L’ODIO E I PRESIDENTI
Ma per Lallà che dice di essere uno straccione niente di ciò è vero. Lui non conosce D’Alterio e al massimo comprava dal marocchino delle autolinee 200 euro di cocaina al mese. Una cocaina – è lui stesso a ribadirlo più volte – di bassa purezza, sporcata e mischiata con la purga, una sostanza “che si fa al bagno“. Il boss, quello alla sbarra per associazione mafiosa, si sminuisce da solo nell’interrogatorio a cui sceglie di rispondere per negare qualsiasi coinvolgimento anche con le estorsioni. Al massimo, sostiene Armando, lui è un piccolo spacciatore, con qualche precedente, che vende a qualche amico la cocaina per campare e mantenersi il vizio. Sì perché Lallà preferisce dire di essere anche lui un consumatore di cocaina e che la spacciava solo per procurarsene altra: “Ero un drogato” – urla a gran voce, quasi da disperato.
“Non stavo al livello di narcotraffico” – sostiene Lallà – “Vendevo 5, 6 grammi di cocaina a qualche amico: metà era droga, metà era purga. Spendevo per comprarla 200 euro. Io sono padre di 5 figli e nonno di 10 nipoti. Siamo una famiglia e una banda di straccioni, siamo morti fame“.
Al che, il pm De Lazzaro gli chiede come facevano a possedere tre Mercedes, poi sequestrate dalla Polizia di Latina (insieme a un vitellino e a due cavalli – ha detto Lallà in Aula) e Lallà, effettivamente provato dal carcere come si può vedere dal video dell’Aula del Tribunale in collegamento dalla Sardegna, diventa quasi disarmante: “Le avevamo in conto vendita io e mio figlio“. Ossia loro erano rivenditori di quelle auto di lusso (una delle quali apparteneva, secondo il capo zingaro, a un Carabiniere) tanto è che il boss di Campo Boario sostiene di aver fatto tanti lavori tra cui quello di commerciare in auto, curare i giardini, imbiancare i muri delle case e fare il pastore di bestiame.
Per quanto riguarda l’intestazione fittizia di un terreno limitrofo al noto centro ludico Country Club Tecariba, a Borgo Isonzo, Lallà sostiene che il bene è di proprietà di colui che dagli inquirenti è ritenuto il suo prestanome: quel Daniele Coppi, per la verità, già condannato in due gradi di giudizio, a un anno e quattro mesi, nel processo Alba Pontina che si svolge a Roma per coloro che hanno chiesto il rito alternativo a quello ordinario (il cui processo, invece, si celebra a Latina). E proprio per intestazione fittizia di beni.
Leggi anche:
ALBA PONTINA: L’APPELLO CONFERMA LA MAFIA DEI DI SILVIO MA PENE RIDOTTE
Niente da fare, come accennato, anche per le estorsioni. Lallà dice di non conoscere praticamente nessuna delle vittime, persino arriva a sostenere di non sapere cosa facevano i figli, ma è consapevole e diventa lucido solo quando deve parlare di Agostino Riccardo e Renato Pugliese: “Bugiardi e malfattori“, lo ripete almeno quattro volte nel corso dell’interrogatorio quasi come un messaggio definitivo che deve arrivare alle orecchie di chi ha ancora qualche dubbio.
Secondo Lallà, è Riccardo – che come Pugliese “sono drogati e ludopatici” – ad aver portato sulla cattiva strada i figli Samuele e Gianluca nelle estorsioni al vivaista di Tre Cancelli o al dipendente della scuola da ballo a Latina, o quelle a carico del noto avvocato nel ramo della assicurazioni Stefano Trotta il quale, a differenza di tanti altri che Lallà dice di non conoscere (ha negato, ad esempio, di sapere chi sia Luciano Iannotta il quale, in questo processo, è citato per via di un’estorsione al suo braccio destro De Gregoris), è per lui una brava persona con cui ha fatto il carcere a Roma.
Sarebbe stato Agostino Riccardo a “spacciarsi per zingaro”, dice Lallà, e a sfruttare il nome dei Di Silvio. Il che è vero ed è cristallizzato sia dalle indagini della Squadra Mobile di Latina che dalle stesse dichiarazioni dell’ex affiliato al Clan Di Silvio. Solo che Lallà piega questo aspetto in un’altra maniera: era lui a dover salvare i suoi eredi dalla cattiva influenza che Riccardo aveva su di loro. Ecco perché è costretto a intervenire, chiamato da Antonio Fusco detto Zi’ Marcello, quando quest’ultimo gli rappresenta che Riccardo, Pugliese e i due figli Samuele e Pupetto hanno estorto e continuano a vessare Davide Malfetta, il ristoratore di Sermoneta da cui tutta la vicenda di Alba Pontina e il pentimento dei due attuali collaboratori di giustizia ha avuto inizio.
Leggi anche:
ALBA PONTINA: LE SOFFIATE DI ZI’ MARCELLO CHE AIUTARONO MASSIMILIANO MORO
Lallà racconta che, dopo essere stato avvertito da Marcello Fusco, indagato per favoreggiamento (è accusato di aver soffiato le indagini della Mobile dal centralino della Guardia di Finanza di Latina), avrebbe rifilato due schiaffoni a quel “grande volpone” di Agostino Riccardo intimandogli di “stare alla larga dalla sua famiglia” e, in seguito, di aver risarcito economicamente Davide Malfetta consegnando il denaro in busta chiusa presso lo studio legale Palmieri di Latina. Per quale ragione ha risarcito Malfetta laddove Agostino e Renato erano, come dice lui, due “malfattori”, e i figli delle vittime di questi ultimi, è una spiegazione che Lallà non riesce a dare compiutamente in Aula, rifugiandosi nella retorica del padre che accorre quando i figli sono in difficoltà.
Leggi anche:
BASTARDA PONTINA (Parte III)
A parte il risarcimento per paura che il ristoratore denunciasse i figli portati sulla cattiva strada dai “bugiardi”, le tesi di Lallà sulla sua estraneità ai fatti estorsivi (una quindicina quelli contestati nel processo, in realtà ben di più come dichiarato da Agostino Riccardo) sono contraddette in toto dagli atti d’indagine e dalle intercettazioni in cui il boss chiede conto dei soldi non solo di questa estorsione ma anche di quelle ai danni di Luigi De Gregoris, recentemente arrestato nell’operazione “Dirty Glass” e braccio destro di Luciano Iannotta. Oppure di altre, come quella riferibile a un negozio in cui moglie e figlia andavano ad acquistare e dove lui stesso si è recato per incutere timore. Ma per Lallà, che dice di non ricordare, al massimo saranno state richieste di sconto, non estorsioni.
Leggi anche:
LATINA, VOTO DI SCAMBIO PER TRIPODI SINDACO E SOFFIATE: ARRIVANO 4 AVVISI DI GARANZIA
Tuttavia, per Lallà, il quadro appare chiaro. Anche Pugliese è uno che va dileggiato in Aula. Non solo bugiardo e malfattore, ma uno “che si dice è mio parente“, “si dice che è figlio di Cha Cha“, ma “non è mio parente“, pur – e qui sta una delle tante contraddizioni delle risposte-sfogo di Lallà – “avendo passato la sua infanzia con mio figlio” (ndr: Ferdinando Pupetto Di Silvio). “Nemmeno Cha Cha mi è niente, un cugino di quarto, quinto grado…se Pugliese voleva dire certe cose perché non le ha dette al suo amico poliziotto, molto intimo“. Un poliziotto che ha già deposto in Aula in questo processo e che ha avuto il rilevantissimo merito di aver portato alla collaborazione Renato Pugliese, già confidente di polizia dal 2014 come da lui stesso dichiarato nella deposizione di novembre 2019. Il punto è che i Di Silvio, come spiegato dal pentito, pensavano erroneamente di trarre giovamento da questo aspetto.
L’orgoglio zingaro, sputato in faccia a chi come Pugliese è in certe assurde logiche “mezzosangue”, che l’imputato fa trasparire più volte, anche quando ammette, in conseguenza della domanda del pm De Lazzaro che evidentemente voleva rimandare all’alleanza per la guerra criminale del 2010, di conoscere Carmine Ciarelli, detto Porchettone, il boss dell’altro grande clan rom del capoluogo. “Lo conosco perché è zingaro, ma è di un’altra etnia“. E usa la sua discendenza rom anche quando, per rispondere alle domande dell’accusa, sostiene che è probabile che “non avete capito, perché tra zingari noi parliamo un’altra lingua“. Citate dal pm e chieste all’imputato anche le vicende che Armando ha nel suo cv criminale: gli spari contro la casa di Velia Casamoneco (ndr: in realtà Casamonica con una vocale scappata all’anagrafe), nonna dei Travali e di Alessandro Anzovino quando quest’ultimo, anni fa, fece la fuitina con la figlia di Lallà, Sara Genoveffa (anche lei imputata, come il marito Federico Arcieri, in Alba Pontina); e l’episodio risalente al 2010 della gambizzazione di Alessandro Zof in via Galvaligi di cui fu protagonista Ferdinando Pupetto Di Silvio, uno dei quattro figli maschi di Lallà.
Sulla politica, Lallà lo scandisce più volte: “Io non ho mai votato, io odio la politica, non conosco questa Gina Cetrone e non andavo ad attaccare i manifesti a 51 anni“. Nega tutto, come per il resto dei reati contestati dalla Procura e, anzi, a domanda dell’avvocato Angelo Palmieri, è disposto ad avere un confronto in Aula con Renato Pugliese e Agostino Riccardo che “trattava come figli” ma con cui non ha mai discusso né di droga né di estorsioni. Il Tribunale si riserva di concedere il confronto, lo scopriremo a breve.
Come, a breve, sempre nel processo, la cui prossima udienza è fissata il 24 novembre (sarà interrogata la moglie di Lallà, Sabina De Rosa), sarà ascoltato per richiesta della difesa di Lallà Di Silvio, l’imprenditore di Sonnino Luciano Iannotta il cui nome, diverse volte, è stato citato in Aula quest’oggi.
Leggi anche:
DIRTY GLASS: IL MONDO DI IANNOTTA TRA “IMPRENDITORIA”, CLAN DI SILVIO E L’UOMO LEGATO A BARDELLINO